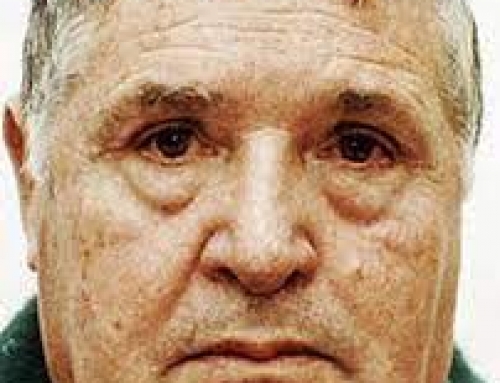Matteo era dunque deciso a continuare, perché voleva portare avanti la sua opera di trasformazione, e aveva bisogno che il corpo malato di Cosa nostra, che si offriva alla vendetta dello Stato, emettesse alcuni colpi di tosse. Noi pure volevamo continuare, perché avevamo un imperativo, che non era solo il vecchio adagio del futti futti che dio perdona a tutti, ma uno più spicciolo.
E si sa, le grandi tragedie non accadono con spirito nobile o ampie vedute, quella è virtù di pochi; le grandi tragedie accadono da pensieri banali, piccole intenzioni. E la nostra intenzione era quella di rispondere a quel finimondo che lo stato stava mettendo contro di noi, il carcere duro, innanzitutto, dal quale ci arrivavano racconti terribili: i nostri parenti privati di luce, aria, compagnia, roba che non si fa neanche ai cristiani più tinti; insomma, con tutti i violentatori di picciriddi e i corrotti che sono liberi, voi ve la pigliate con quattro animelle che non hanno fatto mai nulla di male nella loro vita, se non un poco di sventura? I racconti che arrivavano da posti come Pianosa o l’Asinara sembravano davvero descrivere l’anticamera dell’inferno. […].
E noi stavamo per morire, inutile girarci intorno, bisognava respingere quel massacro che stavamo subendo. Dobbiamo portare avanti la guerra, ci incitava Matteo, forza, qualcuno ci verrà a cercare, qualcuno ci verrà a dire: perché non la smettete? E tutti fantasticavamo il momento in cui qualcuno si sarebbe seduto alla tavolata con noi, e ci avrebbe detto: picciotti miei, allora mettiamoci d’accordo, non è che possiamo continuare all’infinito con queste ammazzatine.
E noi avremmo fatto le nostre richieste. Bagarella, ad esempio, aveva il chiodo fisso del 41 bis, il carcere duro, era quello più impressionato. E aveva tante altre idee, che magari se uno gli dava spago capace che ci metteva come richiesta che sua moglie doveva rimanere incinta una volta per tutte. Altri ancora ce l’avevano con i collaboratori di giustizia.
Dobbiamo fare cambiare la legge sui pentiti, dicevano. Ancora una volta, eravamo chiamati a seminare il terrore per stabilire la pace, a destabilizzare per mettere ordine, a depistare per dare una via. Che poi, a pensarci bene, era tutta una follia, non c’era logica – sì, adesso possiamo dirlo, con la serenità dei superstiti –, non c’era alcuna logica. Ma volete fermarvi un attimo a riflettere su questo paradosso?
Noi chiedevamo allo Stato di abolire delle misure repressive che erano nate proprio a causa di quelle stragi che noi avevamo voluto ed effettuato. Il primo provvedimento che trasferisce 55 mafiosi detenuti dal carcere dell’Ucciardone a Pianosa il ministro della Giustizia Martelli lo ha firmato a Palermo, la sera del 19 luglio.
E senza la strage di Via D’Amelio molti provvedimenti in Parlamento non sarebbero passati, perché le resistenze garantiste erano tante. E allora tanto valeva non fare le stragi direttamente… Le cose devono continuare – ci esortava Provenzano – un po’ di pazienza che tutto si risolve in bene.
Provenzano adesso era il primo a essere convinto che bisognava continuare, ma a modo suo. Ci convinse a spostare gli obiettivi fuori dalla Sicilia. E certo, voleva campo libero da noi. Matteo apprezzava e incoraggiava. Provenzano credeva di poter inaugurare un nuovo regno, non capiva che anche per lui era cominciato il conto alla rovescia.
Sognavamo questo incontro: ci saremmo messi il vestito buono, ci avrebbero invitato in qualche stanza dall’argenteria in vetrina, i passi morbidi sulla moquette, noi con le scarpe buone, non quelle marroni, le altre, come Matteo ci aveva insegnato.
L’accordo in realtà si stava facendo. Ma a nostra insaputa. Noi non eravamo al tavolo. Eravamo parte dell’accordo.