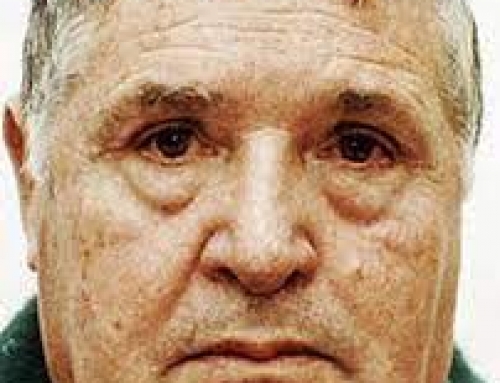Matteo in questa nostra guerra era un generale presente e attento. Ci metteva la faccia, certo, prendeva decisioni, stava soprattutto accorto a che il fronte rimanesse compatto, e niente lo gasava di più che stanare chiunque tra noi non mostrasse la massima adesione al progetto di guerra allo stato.
Stava anche attento, però, a non sporcarsi le mani. Lo faceva per noi, per il nostro bene: più il suo nome rimaneva nell’ombra, più nel nostro territorio potevamo continuare ad agire nella più assoluta indifferenza.
Era incredibile; eravamo in trincea, ma era una trincea tranquilla – in doppiopetto, potremmo dire –, giravamo alla luce del sole, senza che nessuno dicesse né ai né bai, e se qualcosa ci tradiva non era mica per la spirtizza di chi avrebbe dovuto fermarci, ma per la nostra euforia, che a volte ci portava a commettere errori.
Errori Matteo non ne faceva, teneva tutto sotto controllo, sembrava sempre con il pensiero altrove. Però anche lui aveva le sue debolezze. E non parliamo né di auto né di orologi, né di donne o stecche di sigarette intere da fumarsi tra un appostamento e l’altro.
La debolezza di Matteo era consumare qualche piccola vende personale. Anche lui aveva una sua lista nera, solo che non la tirava fuori, non voleva creare confusione nella mischia che c’era. E fu quando il signor Riina disse che sì, era venuto il momento di levarci qualche spina – non solo per senso di vendetta, ma anche per tenerci in allenamento nell’attesa che gli eventi si chiarissero, e per far fare un po’ di festa ai cani che tenevamo al posto del cuore –, che Matteo finalmente accennò un sorriso, e pensò a un uomo in particolare, un ispettore di polizia o commissario o quello che è, catanese, il dottore Rino Germanà, che gli stava molto sui coglioni, anche troppo, per diversi motivi.
Perché era un’anima inquieta, faceva troppe domande, e aveva capito qualcosa della guerra di mafia, e dei Messina Denaro. Ora, in questo caso, la prima cosa che si faceva con un poliziotto che era bravo era di delegittimarlo, con esposti anonimi, lettere, qualche calunnia. La seconda cosa era trasferirlo. E così era stato anche per Germanà.
Però il suo trasferimento per noi fu una punizione, perché nel suo girovagare tra Questura di Trapani e Commissariato di Mazara, tra Castelvetrano e procura di Marsala, in realtà Germanà andava mettendo pezzi su pezzi, ci stava mappando. Aveva scoperto, ad esempio, che eravamo pure dentro le istituzioni, con i nostri suggeritori, e faceva gli schemini con i perdenti e i vincenti della guerra di mafia, e pareva giocasse a quel gioco, nome, cose, città, e a ogni città cominciava ad associare un nome, e una cosa, e poi a tutte le cose il nome dei Messina Denaro.
Lo avevano spostato a Catania, alla fine, ed eravamo tutti convinti che fosse finita lì, anche perché era stato nominato dirigente della sezione della Criminalpol di Caltagirone, incarico prestigioso se non fosse per il fatto che quella sezione non esisteva e non sarebbe mai stata costituita. E nonostante doveva timbrare il cartellino dall’altra parte della Sicilia, lui quando poteva era sempre tra i piedi a Mazara e Castelvetrano, e continuava a girare, a fare domande.
Aveva messo il naso nelle banche, cominciato a indagare su certi notai e logge massoniche. E quindi Matteo decise che la sua spina da levare era Germanà, e che avremmo dovuto ucciderlo. Era tutto pianificato, il 14 settembre del 1992.
L’Italia era nel suo solito caos, con i politici che venivano arrestati, altri che si suicidavano, e ad aggiungere ancora più confusione era arrivata quella specie di guerra civile in Jugoslavia, dove un aereo italiano che doveva portare coperte e aiuti era pure caduto. Quel giorno, al lungomare di Mazara del Vallo, Germanà era a bordo della sua Panda bianca come l’innocenza.
Lo affiancammo con una Fiat Tipo, il motore che accelerava, la marcia in seconda, poi la terza, poi più forte, poi di nuovo la seconda per rallentare, un colpo di clacson, un altro, per farlo girare. Sembrava fatta. Primo colpo di fucile. Mancato. Secondo colpo. Vetro dell’auto in frantumi. Lui, ferito alla testa dalle schegge, accosta e riesce a fuggire. Una scena che pare un cinema. Altri colpi: il commissario è in spiaggia che corre, e ha anche il coraggio di girarsi e rispondere al fuoco. Si getta in mare. Non resta che scappare. Ma questa volta a scappare siamo noi.
E pensare che era stato tutto preparato nel dettaglio, nel villino del fratello di Giovanni Bastone, a Mazara, e Matteo aveva scelto gli uomini migliori tra noi, pure Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano aveva voluto nella squadra: aveva pensato a chi doveva fare da staffetta, a chi avrebbe dovuto «pulire» il luogo dell’attentato. Ma niente, non fu cosa, il diavolo ci aveva messo lo zampino.
E anzi Matteo, dopo, aveva la stessa faccia di uno che il diavolo l’aveva visto in persona, perché ne andava del suo onore e della sua reputazione, e gli veniva in mente quella frase: ci vogliono venti anni per farsi una reputazione, e cinque minuti per distruggerla. È andata male, ripeteva, è rimasto vivo, mentre le radio già davano la notizia, e la storia dell’attentato a Germanà apriva i telegiornali della sera, e qualcuno di noi che commentava, amaro: «Vuol dire che il suo destino era di restare in vita». […].