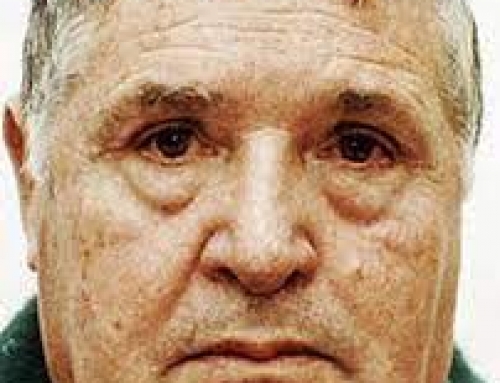Lo avevamo fatto. Avevamo cominciato a uccidere ancora prima di accorgerci che eravamo diventati assassini. Ci rivedemmo, dopo l’omicidio di Salvo Lima. Eravamo già stanchi, ma eravamo solo all’inizio. Le parole furono poche, come se tutto avesse già preso una piega. Altre cose tinte erano in arrivo, e non stava a noi né cambiare né tantomeno fermare il corso degli eventi. Le cose indietro non le lasciamo, ci dissero i palermitani.
Quello che è successo non è niente. E ancora: È una guerra contro lo Stato. Infine: Accadranno cose importantissime. Non per la Sicilia, per l’Italia. Il signor Riina era contento. Si sono aperti dei canali, diceva, e alcuni di noi pensavano, nella loro ignoranza, a dighe e campi da coltivare, e chissà, qualcuno tra noi borbottava anche: vuoi vedere che è già finita e ce ne torniamo tutti a fare i contadini come i nostri padri, finalmente, e tutto questo sbattuliamento della guerra allo stato magari è servito solo per avere un pezzo di terra? Che poi, alla fine, se ci pensate, è da sempre per questo che si fanno le guerre, per la terra, ed è per questo che è nata la mafia, per la terra, ed era sempre questo l’orrore che ci portavamo dietro, il selvaggiume della terra.
Ma non eravamo così ingenui e sempliciotti: sapevamo che i canali di cui si parlava non erano irrigui. Lui, lo zio Totuccio, si riferiva ad altro, al mondo politico. E la teoria era: vedrete che ora succederà un terremoto e qualcuno ci cercherà per avere i nostri voti.
Erano i mesi in cui forze politiche nuove, in effetti, stavano prendendo campo, e tra questi partiti nuovi ce n’era uno del nord che andava molto forte, e Matteo lo seguiva con attenzione perché lui da tempo propugnava l’idea di un partito del Sud, anzi, della Sicilia, tutto nostro, indipendentista, autonomista, sicilianista, e più parole in -ista ci vengono meglio è. E in -ista era l’altra parola con la quale cominciarono ad associarci: stragista. La mafia stragista.
L’ala stragista di Cosa nostra. Qualcuno aveva capito: vedrete che Lima è solo l’inizio. Cose grosse erano in serbo, come recita quel detto: il meglio deve ancora venire. E se dobbiamo ricordare quelle settimane, il periodo tra marzo e maggio, era come essere attraversati da una continua scarica elettrica.
Sembrava che il mondo fosse piccolo, e che avremmo potuto contenerlo nel pugno di una mano. Sì, sembrava che con le nostre mani avremmo potuto sradicare Palermo e il parlamento, ogni aula di giustizia e tutto il ministero. Sembrava che tenessimo in pugno non solo Andreotti ma tutta la Repubblica che stava morendo e quella che doveva nascere; sì, anche quella era nelle nostre mani, rantoli e vagiti, tutto si confondeva, nella nostra annacata.
E quelle nostre mani, che per la prima volta ci sembravano fiere e grandi e non più callose e nodose, non erano mani da contadini o di assassini, erano le mani del potere che tutto può e che decide vita e morte e miracoli. In quelle nostre mani c’era pure il dottore Falcone. Era venuto il momento di serrare il pugno.
Cominciarono così i preparativi per il fatto grande che avrebbe sconvolto il mondo intero. Prima però le famiglie di Agrigento avevano organizzato tutto per un altro obiettivo: il maresciallo maggiore Giuliano Guazzelli. Anche lui era nel nostro elenco. Lo conoscevano bene le famiglie mafiose di mezza Sicilia. E anche se era vicino alla pensione, ci faceva paura la sua memoria portentosa, il modo in cui metteva insieme parentele e relazioni, da Palermo ad Agrigento fino a Trapani.
Fu ucciso sul viadotto Morandi, prima di entrare ad Agrigento, con un armamentario di tutto rispetto: mitra, kalashnikov, un fucile a pompa. Era il 4 aprile. Il giorno dopo si votava per le elezioni politiche. E quei colpi mortali servirono anche per rompere il silenzio elettorale e fare arrivare il nostro messaggio ancora più forte a chi doveva ascoltare.
LA GUERRA ALLO STATO
Vennero giorni sospesi, lattiginosi, tra aprile e maggio del 1992. La Sicilia sembrava immersa in un bicchiere di acqua e zammù, di quelli che a Palermo si bevono per strada per calmare i tormenti dell’estate.
Qualcuno era anche deluso: come? ci avete fatto credere alla grande abbuffata, e invece vi siete fermati all’antipasto, e a un paio di contorni? Dov’è il piatto di portata, il cinghiale arrosto, il vitello grasso, dov’è? Intorno tutto si muoveva come se nulla fosse. Tirava un vento di scirocco, vento pieno di rabbia. E noi la sentivamo, comunque, l’energia. Sembrava che ci fosse come un’onda, potentissima eppure leggera, una marea, ecco, che si disperdeva dal cratere che stavamo preparando.
Sotto quel pezzetto bello e tondo del cielo di primavera, vedevamo Cossiga, Craxi, Andreotti, e i comunisti e la Dc, i giudici della Cassazione e quelli del Maxi, i questori e le squadre mobili, la Rai e Canale 5. Mentre acconciavamo per loro la nostra coreografia, sentivamo bisbigliare, avanzando, sul luogo del disastro, i pompieri e i carabinieri, il papa polacco e i servizi segreti. Scivolavano, come ipnotizzati da un pensiero gelido, «Repubblica» e il «Corriere», i corrispondenti e gli inviati, tutte le vittime e i martiri, le sacerdotesse dell’Ave Maria e il Padre Nostro che sia fatta la tua volontà, ma solo in cielo, però, perché in terra comandavamo noi.
Era nostra la volontà, nostro era il destino, nostro era il dito che muoveva il mondo. Tutti, li aspettavamo tutti, pronti a misurare il vuoto. In tanti erano coinvolti nella preparazione dell’attentato al dottore Falcone, e ognuno sapeva un pezzetto di storia, ma non tutta la messa.
A ciascuno il verso di un salmo che tutti insieme stavamo mandando a memoria. L’Italia continuava come prima, nel suo contorcersi tra arresti eclatanti e crisi economica, le dimissioni del presidente della Repubblica, la guerra in Serbia, la Disney che apriva un mirabolante parco giochi a Parigi.
Il dottore Falcone tenne quello che sarebbe diventato il suo ultimo incontro pubblico, all’università di Pavia. Parlò giusto giusto della famiglia mafiosa di Castelvetrano, «messa con le spalle al muro dalla Procura distrettuale di Palermo».