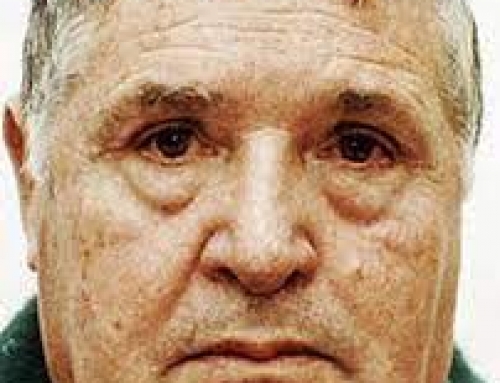A Marsala i rappresentanti delle famiglie erano Vincenzo D’Amico e Francesco Craparotta. Gli spiegammo il da farsi, la necessità di compiere l’attentato. Gli potevamo mettere a disposizione Vito Mazzara, che era campione sportivo di tiro a piattello, oltre a essere un pezzo importante della storia di tutti i trapanesi. Sparava da vero professionista. E già ci fu un primo no. Loro non si sentivano minacciati da Borsellino.
Avevano agganci con tutti, con i politici, con uomini delle istituzioni, e tutti avevano garantito che loro, comunque, erano intoccabili. Anzi, nell’occasione ci avevano ribadito che non era cambiato molto dai tempi di Mariano Licari, il mitico capomafia degli anni Cinquanta.
Più volte qualche giudice aveva cercato di arrestarlo, per «i reati più obbrobriosi», come scrivevano ai tempi, e più volte carabinieri e polizia avevano ribadito per iscritto che Licari godeva di «stima e reputazione» e «non era mafioso». Ecco perché i marsalesi ci dicevano: Cu ni ci porta? Siamo a posto, non abbiamo nessun tipo di problema con Borsellino. Fare una cosa di questo genere ci porterebbe solo problemi. Non avete nessun problema con Borsellino? ’Stu cornuto? ’Stu tinto? ’Stu disonorato?
E pensare che avremmo fornito tutto noi, c’era già una mezza idea: un’autobomba sotto il tribunale, che poi era un’ex scuola, in una piazzetta angusta. Oppure al commissariato di polizia, dove Borsellino dormiva. Ma loro insistevano: Non possiamo mettere Marsala sottosopra, noi stiamo bene qui, stiamo tranquilli. Perché non cerchiamo un altro posto dove c’è meno clamore? Qua non muore solo Borsellino, muoiono magari decine e decine di persone. Con i marsalesi c’erano problemi ogni volta.
Facevano affari in zone non loro senza dare preavviso, si erano appropriati di soldi che servivano per pagare gli avvocati e sostenere le famiglie dei detenuti, pestavano i piedi alla famiglia di Mazara. Questo primo no di quei disgraziati aveva insomma creato un po’ di tensione. E poi qualcuno se l’era cantata. Perché a un certo punto a Borsellino fu rafforzata la scorta.
Quindi, è vero, c’era chi parlava con la famiglia di Marsala, ma c’era anche chi riceveva messaggi. Quattro cornuti ci ero a cuntare tutti cose, commentò Matteo con disprezzo. Ma c’era anche un’altra cosa. Che i marsalesi avevano detto no a Riina e a Matteo.
Avevano espresso il loro parere contrario. E quindi, lo sapete già come poteva andare a finire, no? Perché a un certo momento le strade erano due: o non si faceva l’attentato, o si eliminavano le persone contrarie e poi si andava a fare l’attentato. E noi l’attentato dovevamo farlo, punto.
L’idea iniziale era di sterminare tutta la famiglia di Marsala. Una strage. Troppo bordello. Allora passammo a più miti consigli. Fu così che l’11 gennaio del 1992 furono uccisi Vincenzo D’Amico e Francesco Craparotta. Si era ancora nel clima delle feste di Natale, anche perché a Marsala si usa aspettare la festa della Santa Patrona, la Madonna della Cava, che è il 19 gennaio, per smontare alberi e presepi, rimettere in soffitta statuine e lucine intermittenti, e chiudere i tavoli di cucù e sciumè. Se la prendono comoda.
Un paio di settimane prima, a Tonnarella, in una villa sul mare a Mazara del Vallo, Matteo organizzò una schiticchiata, una mangiata con Totò Riina. Matteo era elegante, sembrava un figurino. Il signor Riina era di buonumore. Venne con una Alfa 164 bianca, e regalò un milione di lire a ognuno dei partecipanti, per comprare un pensiero per le nostre famiglie – che magari in un altro momento avremmo potuto coinvolgere in una bella tombolata tutti insieme, oppure a giocare all’asso che corre o a bestia.
Ma non era questa la serata adatta. E lì Riina si girò verso Antonio Patti e gli disse: Dobbiamo levarci queste spine a Marsala. E poi offrì spumante: mosciandò per tutti. Il 12 gennaio 1992 un tale, Francesco D’Amico, andò dalla polizia. Mio fratello Vincenzo, disse, questa notte non è tornato a casa. È uscito di casa alle sette del mattino, e non è più tornato. Vabbè, sarà in giro. Il fatto è che abbiamo trovato l’auto, lui no. Malamente, pensò il poliziotto.
A compiere l’omicidio fu Antonio Patti, al quale Matteo aveva promesso che sarebbe diventato il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Marsala. E alla famiglia di Marsala, in regalo, sarebbero andate anche tutte le estorsioni fatte nel paese di Petrosino e che finora erano competenza dei mazaresi. E così fu stabilito in una riunione che, dopo gli omicidi, abbiamo tenuto all’hotel Hopps di Mazara.
In contemporanea una signora andò dai carabinieri: mi presento, sono la moglie di Francesco Craparotta. Mio marito questa notte non ha fatto ritorno a casa. Anche gli sbirri sapevano che i due non erano persone qualunque. E qualcosa di grave doveva essere successo. Ma gli faceva strano, perché non c’erano stati segnali di una guerra di mafia in arrivo.
Non sapevano che erano vittime del nostro ragionamento gelido, e che li avevamo uccisi perché erano delle crepe nel nostro svolgimento perfetto delle ammazzatine che volevamo fare. Poi il 7 febbraio, infine, il terzo omicidio. Gaetano D’Amico. Gli sparammo al bar. A questi omicidi partecipava anche un grande amico di Matteo, Vincenzo Milazzo, coetaneo suo, astro nascente della famiglia mafiosa di Alcamo. Che bello che era, Vincenzo. Era tutto: enologo, chimico, sicario, sperto, fimminaro, vincente.
Conosceva tutti nella Alcamo bene: politici, senatori. Faceva la bella vita. Anche lui venne ucciso, da Matteo, a luglio di quell’anno 1992, perché anche lui aveva cominciato ad avere perplessità sulle stragi. E in quel caso Matteo agiva come una specie di ministro dei Temporali. Perché poi avete bisogno di dare etichette, voi. E allora sì, se Siino era il ministro dei Lavori Pubblici di Cosa nostra, se lo zio Ciccio era quello degli Esteri, potete scrivere tranquillamente che Matteo era ed è il ministro dei Temporali, perché arrivava come una saetta e colpiva chi tradiva, in questo caso il povero Vincenzo Milazzo, che si era messo in testa non solo di mettersi contro la nostra strategia, ma anche di diventare lui, il capo.
Amo a virere – diceva – quando cominciano a piovere gli ergastoli… E pensare che con Matteo erano grandi amici, e che insieme avrebbero potuto fare grandi cose. Ma faceva il gioco delle tre carte, un po’ diceva sì, un po’ diceva no. E conosceva gente nei servizi, così dicevano, e si faceva delle riunioni tutte sue. Un tale, non si capisce se per prenderlo per fissa o perché ci credeva davvero, gli aveva anche prospettato l’idea di una guerra batteriologica, avvelenando degli acquedotti, e lui era sbottato: ma siete dei pazzi!
Matteo non poteva permettere che si facessero queste deviazioni, queste trattative nelle trattative, che si poteva finire in un labirinto, come quello che hanno fatto a Gibellina dopo il terremoto. E proprio da Gibellina stava tornando l’amico nostro Vincenzo, quando lo incrociammo con l’auto per dire che Matteo lo aspettava al solito posto per un chiarimento.
E il solito posto era questo malaseno che utilizzavamo per la droga, e quando Milazzo arrivò non ebbe tempo di dire né ai né bai. Aprì la porta. Ci vide tutti in piedi ad aspettarlo, uno di noi con l’arma già pronta. Disse soltanto: Spara, cornuto.
E gli sparammo. Certo, con un po’ di dispiacere. Ma il nostro motto era: non essere deboli. Infilammo il corpo in un sacco nero. Matteo fece una fossa con l’escavatore. E addio Milazzo. Qualche giorno dopo, nella stessa fossa ci infilammo un altro sacco nero. Dentro, c’era la fidanzata Antonella. Lei la strangolammo. Faceva troppe domande, era squieta, ci conosceva tutti. Sì, la strangolammo. Anche lei, su appuntamento, nello stesso posto. Alle donne noi non abbiamo mai sparato.