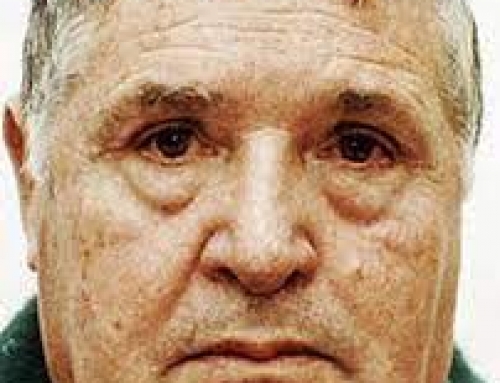E a proposito di miti. Non ci ricordiamo il periodo esatto in cui le condizioni di Don Ciccio si aggravarono. Era stanco, era vecchio, era malato. Ma già c’era un capo, che gli anziani stavano forgiando come in certe leggende nordiche, o come quell’altro mito della dea partorita dalla testa di Zeus.
Perché dalle cosce della mamma, certo, dal seme fertile della nostra storia, anche, e dalla lingua di pietra dei nostri padri era venuto fuori Matteo; ma soprattutto era venuto fuori dalla testa del signor Riina, che in lui vedeva non un capo qualsiasi, ma il capo, l’erede, quello che avrebbe affrontato la prova più dura ed esaltante di tutte: l’attacco allo Stato, la resa dei conti. E di tutti i segreti che custodivamo questo era quello più potente, tanto che, paradossalmente, di Matteo Messina Denaro si è cominciato a parlare solo molto tardi, solo con la sua latitanza.
È dovuto scomparire per farsi notare, diavolo di un Siccu. Forte e dritto come un palo del telegrafo, lo avevamo visto iniziare con i primi omicidi, poi con la guerra di Partanna, aveva fatto da paciere ad Agrigento, e in un vìriri e svìriri, in men che non si dica, a un certo punto Riina non ecideva nulla senza averne prima parlato con Matteo, e quasi nessuno ricordava più che fine avesse fatto Don Ciccio; a noi interessava solo di Diabolik, perché non c’era cosa che non si muoveva se lui non diceva ai o bai.
E anche Mariano Agate, il boss di Mazara del Vallo, a un certo punto capì l’antifona; chissà, magari pensava che, con la malattia di Don Ciccio, il capo sarebbe stato lui – gli toccava per anzianità – e non il giovin Messina Denaro.
Ma si sbagliava, perché noi abbiamo sempre saputo scegliere le competenze, privilegiare il ricambio generazionale, e lo facciamo in maniera veloce e silenziosa, e Agate fece il giusto passo indietro. Poi faceva trasi e nesci dal carcere, e se non era in carcere aveva comunque la libertà vigilata, e quindi si levò di mezzo da solo, e avvenne senza cerimonie e giuramenti e sacramenti e chiamate di santi.
Non aveva bisogno di punciute, Matteo (che poi, a dire la verità, a noi il sangue ha sempre fatto impressione), né di baci, abbracci, padrini, formule da recitare, santine in mano. Era nel suo destino diventare boss, la sua infanzia alla fine era stata questa: ingannare il tempo, nell’attesa di diventare il capo.
Anche nel rapporto con le donne sembrava prematuro, Matteo. Mentre noi sognavamo amplessi clandestini in macchina con le ragazze dalle cosce color madreperla dei nostri paesi – cosce sempre chiuse per noi come le porte della chiesa di padre parroco quando ci veniva l’ansia della confessione – lui aveva un giro tutto suo, addirittura fino a Palermo, con il nostro amico Lillo Santangelo, che lì studiava Medicina.
Era un tipo scialuso Lilluzzo, e lo chiamava sempre a Matteo: vieni qua a Palermo, che ci sono le fimmine vere, ti spiego io come si fa, e lui, Matteo, correva. E molte avventure gli fece passare, prima di essere ammazzato su ordine di Don Ciccio, che era anche suo padrino.
Perché se c’era qualche sgarro da riparare, Don Ciccio non guardava in faccia a nessuno, neanche all’amico di suo figlio, neanche al suo figlioccio, e Lillo Santangelo era stato trovato morto, solo come un cane, sparato da Giovanni Brusca una mattina presto, vicino all’università; che Brusca manco sapeva come si chiamava, era venuto zio Ciccio in persona da Castelvetrano, un giorno, a indicarglielo da lontano. E a dire: iddru.
E a Palermo c’erano queste signore favolose, ci raccontava Matteo, tutte mature, pettinate, pulite, che avevano accenti perbene, e ci dicevano: da dove venite? Castelvetrano? Grazioso come paese. Ma per noi mica era paese, Castelvetrano, era città, come Marsala, Mazara, Trapani. Paesi erano Partanna, Santa Ninfa, Vita.
Manco Salemi era paese, va’, però per loro se non era Palermo era paese, e se non era brutto era grazioso, e stop; poi non ricordiamo altro, perché finalmente si ficcava e ciao. E poi Matteo fu anche quello che ci insegnò i segreti delle straniere, perché lui andava la sera a Selinunte, che d’estate c’era sempre pilu, e le acchiappava; anche se non sapeva le lingue, bastava guardarle.
E noi a chiedergli: Mattè, ma è vero che le francesi ce l’hanno rasata? E le tedesche? È vero che ci hanno le ascelle pelose? E le spagnole come lo fanno? Poi anche questo giro era finito, perché lui si era innamorato di una tedesca – che poi era austriaca, ma per noi era tedesca –, una ragazza che lavorava alla reception del Paradise Beach Hotel di Selinunte, e anche lì c’è scappato il morto, questa volta per gelosia, caso unico nella storia di Cosa nostra: il vicedirettore, Consales si chiamava, che era pure lui innamorato della zita di Matteo e che una volta aveva osato cacciarci dal suo albergo dove la sera andavamo a fare i nostri giochi senza frontiere dell’acchiappo.