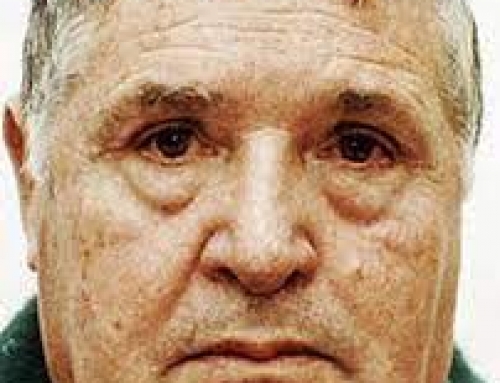A proposito di armi: quelle per noi non erano un problema, non lo erano mai state. Così come ci sono le guide turistiche che vi consigliano i posti da visitare in Sicilia occidentale – le saline di Trapani, Erice, il Satiro a Mazara, le calette di Favignana –, noi avremmo potuto scrivere una guida su come girare la Sicilia tra un deposito di armi e l’altro, tra un covo pieno di esplosivo e un magazzino rifornito di kalashnikov, che erano utilissimi per colpire quelli che giravano con l’auto blindata. E non dovete pensare solo a magistrati, politici e scorte.
Le auto blindate ce le avevano anche molti di noi, soprattutto quelli che più si scantavano che li facevamo fuori, e allora ricorrevano a una specie di scorta, e all’auto blindata fatta venire da fuori. E a volte accadeva che magari noi non lo sapevamo che dovevamo fare a uno, ma quello cominciava a girare con l’auto blindata e, insomma, si mangiava la polvere – excusatio non petita, come dicono i latini –, e quindi ci toccava ammazzarlo. Nell’indifferenza generale, avevamo trasformato il nostro territorio in una santabarbara. Lo facevamo da tempo.
Accumulavamo armi come facevano i nostri padri e i nostri nonni, o come da ragazzini facevamo razzia di fuochi d’artificio per le masculiate delle feste del santo del paese, e che a noi invece servivano per i nostri primi crudeli esperimenti sui gatti. Perché c’era sempre bisogno di armi, in Sicilia. Per difendersi dallo stato, per attaccare, in caso qualcuno ci avesse dato l’ordine, per fare la rivoluzione o per impedire di farla, non importa.
Avevamo i pezzi. Ed erano pronti all’uso, perché i più giovani, da noi, prima ancora che con gli omicidi, le sparatine, con gli incendi e le ammazzatine, cominciavano la loro carriera in Cosa nostra così, pulendo le armi, mettendo il grasso o il petrolio, per togliere le ossidazioni, levare i residui di polvere da sparo e le incrostazioni.
E poi bisognava fare l’inventario di pallottole e munizioni. E l’inventario era un compito noiosissimo ma fondamentale, come in quel film sul karate dove c’è il giovane che fa «dai la cera e togli la cera» per imparare a combattere. Valeva anche per noi.
COME DIVENTARE UN “BUON MAFIOSO”
Se volevi diventare un buon mafioso, non ti servivano né la punciuta, né la prova del fuoco – quella prima o poi veniva per tutti – ma, semplicemente, dovevi dimostrare di essere in grado di tenere in buone condizioni un fucile, saper passare il grasso su un mitra, contare i sacchi di esplosivo, e tenere il conto delle famiglie alle quali le armi appartenevano, perché tutto era in comune, è vero, ma ogni famiglia a tempo debito poteva anche – per cortesia – reclamare il suo; e se, ad esempio, Matteo voleva quelle pistole a cui lui teneva tanto, perché un giorno gli andava di fare un omicidio così, con un’arma piccola, e ’sta pistola non spuntava fuori, erano dolori, e capace, non stiamo babbiando, che poi la pistola era per te.
Dalle istruzioni per la manutenzione delle armi, passavamo poi a quelle per gli omicidi. Le armi andavano provate, prima. Perché, a meno che uno non nasce imparato, come Matteo, sparare a un uomo non è affatto facile. Poi bisognava capire quante persone dovevano essere a farlo: due con una moto? Una squadra per bloccare la strada? I colpi dovevano essere vicini, certo, ma non troppo, per evitare gli schizzi di sangue, che erano sempre una camurria. Nell’esecuzione da manuale, i colpi erano sempre tre: uno per fare cadere la vittima a terra, il secondo per ferirla, il terzo in testa per finirla. Senza ferocia, senza accanimento: non siamo gente cattiva.
Ma siccome c’erano sempre impirugli, un conto era il manuale, un conto era la realizzazione. Avevamo depositi dappertutto, e senza particolari precauzioni. Non c’erano caveau, né doppifondi segreti. Ci servivamo delle cave tra Mazara e Marsala che non avevamo ancora riempito di rifiuti, ma che utilizzavamo allora come deposito per armi, auto rubate, carcasse, o come alloggio di fortuna – con una brandina e una cassa d’acqua –, per qualche regolamento di conti o come poligono di tiro per le nostre esercitazioni. Avevamo depositi negli impianti di calcestruzzo, nei magazzini dei nostri frantoi, nei garage dei palazzoni alla circonvallazione di Palermo, vicino l’ospedale, in edifici storici abbandonati, nelle cisterne di acqua che assetavano i campi, nelle stalle, nelle cappelle, nei pozzi. […].
Noi avevamo i depositi di armi da apparecchiare come presepi. L’ambaradan è lo stesso, e comprende le lucine degli alberi, magari, i cavi e i cavetti per fare l’effetto dell’acqua che scorre, e il cartone pressato per le montagne; insomma, tutto un corredo di cose, di cavi e detonatori, di mirini e silenziatori. E avevamo anche i telecomandi.
I telecomandi camminavano a coppia, come i carabinieri. Uno era ricevente, l’altro trasmittente. Li mettevamo in sacchetti separati, per non confonderli. A Palermo, in Piazza Maio, in un deposito messo a disposizione dalla famiglia di San Lorenzo, ne avevamo ben cinque coppie.
Una venne utilizzata per la strage di Via D’Amelio. Due vennero distrutte dopo la strage per evitare che fossero trovate. Le altre due le prese Matteo, insieme ad alcuni detonatori. Li nascose nella sua Alfa 164 che faceva invidia a tutti per come l’aveva personalizzata che manco Diabolik.
Aveva una specie di portabagagli segreto, che apriva con un pulsante. E una volta aveva chiesto a un amico suo meccanico di fare quella cosa che si vedeva nei film di 007, con i fari che si giravano e diventavano dei mitra. Ma l’amico suo ci aveva provato e riprovato e non c’era riuscito. E poi era sparito. Si vede che tanto amico non era.