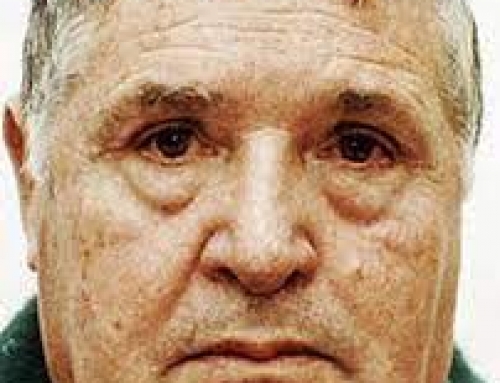Perché di noi in tanti sapevano già a fine dell’Ottocento; c’erano stati importanti investigatori che ci avevano visto giusto. Al procuratore del re, nel 1898, il funzionario di polizia di Palermo, Ermanno Sangiorgi, aveva inviato in poco tempo 31 rapporti che descrivevano la mafia e quello che oggi chiamate «Mondo di mezzo». Rimasero lì.
Nell’anno 1900 tondo tondo Luigi Sturzo aveva scritto pure un dramma teatrale, La mafia, perché non c’era ancora la tv e il teatro era il modo per arrivare a tutti. E a un certo punto uno degli attori dice: «La mafia serve per domani essere servita, protegge per essere protetta, ha i piedi in Sicilia ma afferra anche a Roma, penetra nei gabinetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, viola segreti, sottrae documenti…». Nel 1900! E poi c’erano stati Cesare Mori, e Dalla Chiesa che, ancora prima di essere prefetto a Palermo, aveva scritto un rapporto investigativo, chiamato «dei 114», nel 1971, dopo l’omicidio del procuratore Scaglione. E noi come sempre avevamo scelto il tempo dell’attesa, con il nostro mantra, l’autodifesa: calati juncu. E la piena passò.
Perché ancora una volta il caso prevalse sull’ordine e sull’organizzazione, le invidie e le gelosie come fiumi carsici tornarono a esplodere in superficie e furono violente. Povero dottore Falcone, sperava di prendere il posto di Caponnetto alla guida dell’Ufficio Istruzione di Palermo; gli preferirono un altro, Antonino Meli. Il pool venne smantellato. E loro tornarono a essere tutti come piaceva a noi: disorientati.
Il dottore Paolo Borsellino se ne andò a fare il procuratore a Marsala, e questo non lo avevamo messo in conto e fu, scusate l’eufemismo, come avere infilato un dito nel culo. Schivi la granata, e ti colpisce la scheggia. E qui dobbiamo dire che Borsellino a Marsala si era messo a fare indagini, a curiosare, a chiedere, e per la prima volta avevamo il nemico in casa.
E noi pensammo a come farlo fuori, solo che ogni volta che eravamo convinti il piano saltava in aria, un po’ perché i palermitani volevano che si facesse una cosa discreta, un po’ perché qualcuno si buttava pentito, un’altra volta perché ci dissero: statevi buoni, che prima dobbiamo aggiustare ’sta cosa del Maxiprocesso.
E il dottore Falcone? Non lo avevamo perso di vista. Prendeva colpi, ma non perdeva l’ambizione. Voleva diventare procuratore aggiunto. Nel frattempo, quello che chiamavano «il Corvo» spediva lettere ai giornali su certe sue scorrettezze, e chi gli voleva bene cominciò a parlare di «delegittimazione». Scampò per miracolo a un attentato esplosivo tra gli scogli dell’Addaura, dove aveva preso un villino. Divenne procuratore aggiunto, ma il suo capo, Giammanco, non era proprio il migliore dei colleghi, per lui.
L’obiettivo era stato raggiunto: Palermo gli era diventata invivibile. E lui che fa? Cornuto di un giudice, se ne va a Roma, a fare il dirigente degli Affari penali al ministero della Giustizia, su invito del ministro Claudio Martelli. Quelli di noi più ingenui dicevano: bene, ci è finita, se ne va a Roma a fare la bella statuina per il ministro che vuole fare credere che l’Italia sta combattendo davvero la mafia, quando poi a Palermo la mafia vota il suo partito. E invece non sapevano con chi avevano a che fare.
Perché il dottore Falcone cominciò a fare circolari, proposte di legge, di decreti. Un provvedimento, ad esempio, per contrastare il riciclaggio. Un altro, che aggravava le pene per i mafiosi e prevedeva sconti di pena a chi si dissociava. Un altro ancora, per sciogliere i comuni inquinati dalla mafia. E poi un altro per creare un fondo di sostegno a chi denunciava l’estorsione. Minchia, peggio di una retata.
E poi l’istituzione, a novembre del 1991, di una specie di super procura, una polizia speciale, una sigla che abbiamo imparato a vedere spesso nelle pettorine di chi bussa alle prime luci dell’alba per entrarci in casa e fare delle perquisizioni, o portarci in carcere: la Dia, Direzione Investigativa Antimafia. Ma non era meglio che se ne restava a Palermo, il dottore Falcone? Da quella maxi ordinanza del novembre del 1985, che in pratica ricapitolava una specie di storia della mafia, ne nacque un processo, così grande che lo chiamarono Maxi.
Ma non era tanto il numero di imputati a preoccuparci, quanto l’idea di fondo, il teorema che ci vedeva come organizzazione, uniti e definiti. Se si mette nero su bianco ’sta cosa è finita, dicevano gli avvocati. Perché?, gli chiedevamo (mentre bestemmiavamo perché è facile corrompere un giudice quanto è impossibile fare parlare chiaro l’avvocato…).
Perché, rispondevano quelli, mentre preparavano notule di spese per ogni trasferta, colloquio, «studio pratiche» e pure per le «telefonate» – ci mancava solo la voce: spiegazione di come te la stanno mettendo in culo. Perché, ti dicevano, se passa il teorema che noi sappiamo essere infondato, vero? (risatina, noi non ridevamo, l’avvocato si sistemava il riporto e continuava), se passa questa idea, siete fottuti. Ma quale idea? Quella che siete tutti una cosa.
Non capite cosa significa? Che in pratica tutti rispondete di tutto. Perché dietro c’è «l’organizzazione». Ammazzate a uno? E vale per chi lo ammazza, per chi porta la macchina, per chi dà l’ordine… ’U capistivo?! L’avevamo capito. Ed eravamo fottuti.
LE SENTENZE DEL “MAXI”
E così arrivò la sentenza della Corte d’assise di Palermo, il 16 dicembre del 1987. Pochi mesi prima, Maradona aveva fatto vincere al Napoli il primo scudetto della sua storia. E il dottore Falcone aveva fatto vincere all’antimafia il suo primo campionato. Come gli aveva detto una volta Michele Greco, il Papa, durante un interrogatorio: «Lei è il Maradona del diritto, quando prende la palla non gliela leva più nessuno».
La sentenza ci aveva letto nelle viscere delle nostre paure, perché condannava tutti i rappresentanti di Cosa nostra a Palermo e provincia, non solo Riina e Provenzano, ma tanti altri, dai soldati semplici ai capi. E il giudice aveva ritenuto che noi eravamo una cosa sola, una Cosa nostra, che funzionava con le famiglie, le commissioni, i mandamenti, la cupola. E ci aveva fatto la fotografia, con la guerra di mafia, gli omicidi, le strategie.
Poi era venuta la sentenza di appello del 12 dicembre del 1990; l’Italia era un po’ più distratta, c’era meno clamore, e così eravamo riusciti ad avere un bel po’ di assoluzioni. Maradona aveva fatto vincere al Napoli il suo secondo scudetto, quelli del pool invece avevano perso punti. Tornavamo in partita. Riina e Provenzano se ne uscivano bene, e se loro erano tranquilli anche noi dovevamo esserlo. Mancava solo la Cassazione, l’ultima aggiustatina.
[…]In Cassazione, con un’interpretazione rigorosa – appunto – della legge, tra un hic et nunc, un ope legis, un ad hoc, un sed etiam, un’interpretazione a trasi e nesci, eravamo riusciti a fare scarcerare 40 boss imputati del Maxiprocesso. E qualcuno strepitava, parlava di «errori plateali», «volontà di liquidazione del lavoro di pm e giudici», ma perché? Non sono giudici anche quelli? Tutto a posto, dunque, tutto in ordine, commentavamo sazi dei brocioloni addentati nei nostri pranzi domenicali.
Senonché ti spuntò bello bello il ministro della Giustizia Martelli che decise, su suggerimento del dottore Giovanni Falcone, di giocarsi la matta. E la matta era la rotazione dei giudici, come in certi film polizieschi, quando scoprono che la giuria è corrotta e la cambiano all’ultimo, no?
Ecco, quei film non hanno inventato nulla. Il 23 ottobre del 1991 il Maxiprocesso venne iscritto in Cassazione. E non era più assegnato al giudice che noi volevamo. Era un altro. La prima udienza si tenne il 9 dicembre del 1991. Erano i giorni in cui veniva firmato il trattato di scioglimento dell’Unione Sovietica, la dissoluzione di un impero. Ci sembrava un cattivo presagio