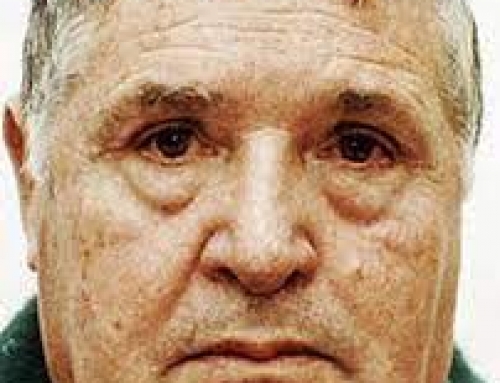Andavamo avanti di riunione in riunione. C’era fretta, era cominciato un conto alla rovescia. A un incontro c’erano tutti i capimafia siciliani, ovviamente anche Matteo. Ormai la guerra allo Stato era decisa. E bastava un’occhiataccia d’u Siccu per zittire quelli che ancora tentavano di capire che fine avessero fatto tutte quelle alleanze che avevamo costruito negli anni, e che furono costruite dai nostri nonni, e che sempre ci portavamo dietro; quel bagaglio di senatori e giudici, eminenze, eccellenze e riverenze, che sono stati sempre al nostro fianco. Dove sono?
Nessuno osava chiedere, nessuno rispondeva. Non funzionano più, si limitò a dire Matteo, beddro spicchio, mentre Zi Totò sembrava un disco rotto, e ripeteva un mantra in continuazione: bisogna fare la guerra per fare la pace, ripeteva. Ma noi eravamo storicamente nemici di ogni forma di guerra e di ogni forma di pace: ci piaceva l’aridità dei sentimenti, se no non saremmo stati Cosa nostra, ma terroristi, banda armata, partito politico, fate voi, ma non certo Cosa nostra.
Ma questo a quanto pare non interessava, dal momento in cui Matteo ci spiegò che avremmo fatto attentati, e per fare attentati bisognava sistemare quel famoso elenco, cominciare a stabilire le priorità. In cima c’era il dottore Falcone, che è già un morto che cammina e non lo sa, ma poi bisognava mettere un po’ tutto in ordine.
A chi volevamo sparare: ai politici, a Salvo Lima, a Ignazio Salvo, a qualche cornuto sbirro, altri magistrati. Scrivevamo. Tipo il gioco nomi-cose-colori-città, scrivevamo di fretta, che le idee buone duravano un attimo. Gli uffici postali. Ottimo! I tralicci dell’Enel. Grande idea! Le questure e le caserme. Giusto! Le sezioni della Democrazia cristiana. Perché no?
Lo vedete che quando volete il cervello vi funziona?, ci esortava Matteo. Continuate! Continuate! Vogliamo il caos. Il rosso e il giallo sono i colori della Sicilia – ci sorprendemmo a immaginare – e diventeranno i nostri colori, rosso come il sangue, come la terra sollevata dall’esplosivo, giallo come il sole che illuminerà la nostra guerra, perché faremo tutto di giorno, senza paura, noi, che in quel momento cominciavamo a sentirci non solo Cosa nostra, ma anche una cosa sola, unica, contro tutto il mondo. Ci sembrava di rendere giustizia a quella visione dello scrittore Leonardo Sciascia: tutta l’Italia che diventava il nostro campo minato, tutta l’Italia che diventava Sicilia.
Sì, ma se chiedono chi è stato, noi che diciamo? Anche per questo ci fu una risposta.
Ci firmeremo Falange Armata. Che significa? Nessuna risposta.
LA FALANGE ARMATA
[…] Antica la promessa, nuova la sigla. Falange Armata divenne la nostra firma. Per le cose piccole come per le cose grandi, le telefonate e gli attentati, e cioè tutto quel teatrino di cartapesta che stavamo mettendo su. Pronto, chi parla? Falange Armata. Chi ha fatto saltare in aria i giudici? Falange Armata. Chi ha mangiato la torta? Falange Armata. Chi c’è dietro la piovra? Falange Armata.
Tra il 1990 e il 1994 sono stati rivendicati con questa sigla almeno una ventina tra omicidi e attentati. Pure le stragi del ’93. E quando al telegiornale si parlava di questi fatti, e della rivendicazione, noi sorridevamo di contentezza per la nostra spirtizza e di soddisfazione, molta soddisfazione.
Alla fine bastava così poco: mettere la firma di un altro, inventarsi un nome, e quelli avrebbero cercato le Brigate rosse – che in Italia ancora erano di moda –, le Brigate nere, le bande armate, l’estrema destra, i comunisti e gli squadroni. In quanto spirtizza sapevamo che sarebbe durata poco, ma ci avrebbe dato un vantaggio, che per alcuni era il vantaggio della fuga, per altri quello del disorientamento.
E i catanesi, che tanto avevano mostrato resistenza al nostro piano, furono i primi, però, a sperimentare l’utilizzo di quella sigla, come nel caso di una piccola prova che fu fatta a Catania, tanto per fare scruscio. Ed è una cosa che ci dispiace che oggi non ne parla più nessuno, perché fu invece una tappa importante del nostro percorso. E ci riferiamo a un attentato niente di meno che a casa del più popolare presentatore tv italiano, che non era Maurizio Costanzo, ma Pippo Baudo. E il 2 novembre del ’91, giorno dei morti, facemmo esplodere della dinamite nella casa di villeggiatura di Pippo Baudo, a Santa Tecla, sotto la celebre Timpa di Acireale, tra il mare e l’Etna.
Un paesaggio grandioso, ideale per fare ritrovare la calma e la serenità a una persona così famosa come lui. E noi la casa l’avevamo letteralmente distrutta. E avevamo scelto Pippo Baudo perché qualche giorno prima lui, siciliano, aveva parlato male della mafia in tv; aveva chiesto addirittura leggi speciali. Ma perché non pensava a Fantastico, a Sanremo, ai miliardi di piccioli che gli davano la Rai e Berlusconi per contenderselo? E quindi i catanesi avevano deciso che Baudo poteva essere il primo a testare la nostra nuova linea, e la nostra nuova firma. Non era né per soldi, né per estorsione. Solo per questo.
Gli pareva che la notorietà e il successo lo rendevano intoccabile? Erano venuti di notte dal mare, erano entrati segando le barre del cancello, avevano piazzato l’esplosivo a ridosso dei muri portanti. Il botto e il bagliore avevano svegliato mezza città. Firmato: Falange Armata. […].
Quel nome, Falange Armata, ci rendeva intoccabili, quasi dei supereroi; era un viavai di armi ed esplosivi, di apparecchi e di telecomandi. Progettavamo attentati: dal giudice a latere del Maxiprocesso, Piero Grasso, a Di Pietro, quello di Mani Pulite. Facevamo così tante telefonate anonime che a un certo punto non trovavamo più gettoni in tasca da utilizzare nelle cabine, e i giornali cominciarono a chiamarci «i falangisti», tracciando origini storiche («La Spagna di Franco…», per esempio. E chi la doveva conoscere? Per noi l’unico Franco era quello di Franco e Ciccio), esaminando i precedenti, che noi neanche sapevamo.
È ovvio che Falange Armata non era farina del nostro sacco. A noi la parola falange ricordava solo il primo dito che stoccavamo dalla mano di qualcuno quando cominciavamo i nostri famosi interrogatori. Parla, cornuto!, e prendevamo il dito medio e glielo piegavamo all’indietro fino a sentire una specie di crack, puntandogli contro la lama del nostro liccasapune. E quella sigla era arrivata a noi in dote, anche se non sappiamo spiegarvi bene in che modo; forse un giorno anche questa sarebbe una storia da scrivere. […]